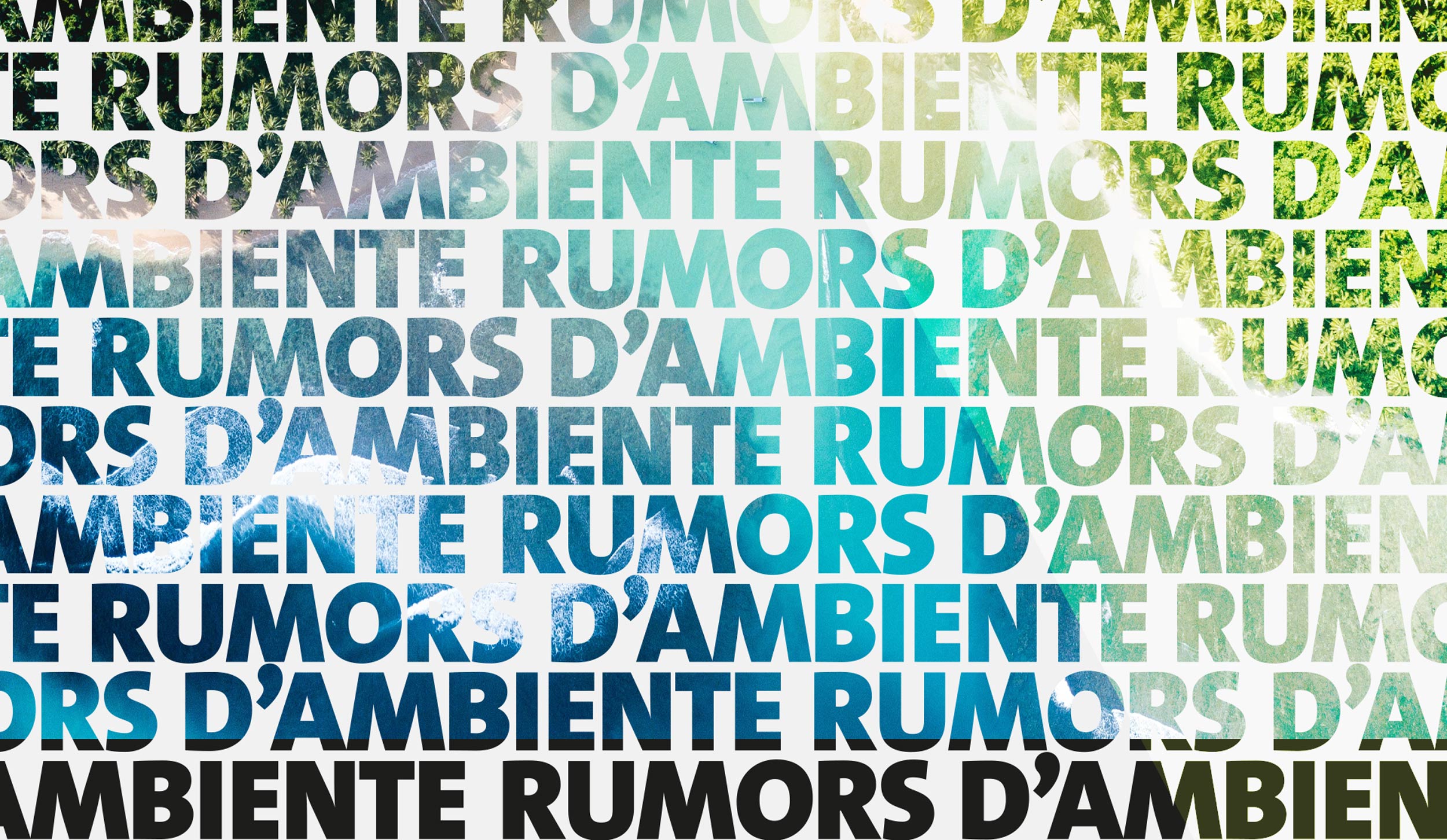Cina, USA ed Europa: i dazi aprono una nuova “guerra commerciale”?
Nel contesto geopolitico ridisegnato dalla rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del 4 novembre 2024, la gestione degli accordi commerciali nel settore dell’automotive potrebbe cambiare significativamente. Tra i grandi Paesi produttori, Stati Uniti e Cina rappresentano i principali attori dei possibili cambiamenti, con ricadute sull’economia globale e sull’Unione Europea, costretta a giocare una partita in difesa, per rispondere alle mosse di questi due grandi colossi spinti da obiettivi e interessi divergenti.
Dazi e sanzioni: cosa aspettarsi da Trump (e da Musk)
Donald Trump, nel quadro del suo programma di ritorno a una politica commerciale protezionista, ha annunciato l’intenzione di imporre tariffe elevate sui veicoli importati, con un focus particolare su quelli cinesi. Questo approccio si innesta in una politica già avviata dall’amministrazione Biden, che nel maggio 2024 ha drasticamente aumentato i dazi sulle auto elettriche cinesi, portandoli dal 27,5% al 102,5%. Ma non solo, ad essere colpite da queste misure protezionistiche anche le batterie al litio (con dazi dal 7,5% al 25%) e pannelli solari e semiconduttori, con un aumento dei dazi del 50%.
La seconda presidenza Trump è iniziata all’insegna degli annunci di inasprimento delle politiche protezionistiche in diversi settori industriali tra cui i veicoli elettrici. La sua amministrazione prevede di eliminare i sussidi da 7.500 dollari per l’acquisto di BEV e ritirare i fondi residui del piano di Joe Biden, pari a 7,5 miliardi di dollari, destinati alla costruzione di infrastrutture di ricarica. Queste risorse saranno reindirizzate verso la lavorazione di minerali strategici e il rafforzamento della filiera interna delle batterie, considerata cruciale per la sicurezza nazionale.
Trump ha anche annunciato l’intenzione di imporre dazi globali sui materiali per batterie, riducendo ulteriormente la dipendenza dalla Cina. Tuttavia, le sue politiche protezionistiche non si fermano qui: oltre ai dazi al 100% già introdotti dall’amministrazione Biden sui veicoli elettrici prodotti in Cina, il neopresidente ha promesso di colpire le automobili cinesi prodotte in Messico, per impedire che queste entrino nel mercato statunitense attraverso la frontiera meridionale. Inoltre, il tycoon ha attaccato i costruttori europei, accusandoli di esportare auto negli Stati Uniti senza una reciprocità adeguata. Particolarmente preoccupata è Stellantis, che sta considerando di trasferire parte della sua produzione dagli Stati Uniti al Messico. Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% su ogni veicolo venduto da aziende che decidessero di spostare la produzione fuori dagli USA. Al contrario, si è detto pronto ad accogliere con favore le case automobilistiche straniere che intendano aumentare la loro produzione sul suolo americano, offrendo incentivi come sconti fiscali, minori costi energetici e una burocrazia semplificata.
Tuttavia, queste misure potrebbero rallentare l’adozione dei veicoli elettrici, penalizzando vendite e produzione interna. Inoltre, l’aumento dei prezzi sui veicoli importati rischia di generare tensioni commerciali non solo con la Cina, ma anche con partner storici come l’UE e il Giappone. In un contesto di crescente protezionismo, la politica commerciale di Trump rappresenta una continuazione e un’intensificazione della stretta già attuata dall’amministrazione Biden, confermando il cambio di rotta rispetto a decenni di globalizzazione economica.
In questo contesto un ruolo fondamentale è giocato da Elon Musk, nel duplice ruolo di capo del DOGE, il nuovo Department of Government Efficiency annunciato dal presidente eletto, e di capo – tra le sue molte attività – di Tesla, la più grande azienda al mondo insieme alla cinese BYD per numero di auto elettriche vendute. Seguendo un ragionamento controintuitivo, proprio Musk potrebbe addirittura trarre un vantaggio dall’abolizione dei sussidi alle BEV. «Togliete le sovvenzioni. Questo aiuterà solo Tesla» ha scritto proprio il multi miliardario sudafricano in un post del 16 luglio 2024 su X, la piattaforma social che possiede. Come ha scritto Daniel Ives, analista tecnologico di Wedbush Securities, il taglio dei sussidi «danneggerebbe in particolare GM, Ford, Stellantis e Rivian», mentre «consentirà a Tesla di respingere ulteriormente la concorrenza di Detroit». A perdere terreno, si legge nell’analisi riportata da Cbs News, sarebbero dunque i concorrenti che rincorrono Tesla, lasciando a quest’ultima lo scettro di leader indiscusso del mercato. «Tesla verrebbe solo sfiorata da un’eventuale cancellazione in blocco dell’Inflation Reduction Act, data la sua posizione dominante sul mercato» conferma un’altra analisi di Fortune Italia.
Come risponderà la Cina
La Cina, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e nella lavorazione di minerali critici per le batterie, potrebbe reagire diversificando le sue esportazioni verso mercati meno ostili, come l’Europa o il Sudamerica. Aziende cinesi come Byd e Chery hanno già avviato politiche di insediamento nel territorio europeo dei propri stabilimenti produttivi, una misura che gioca d’anticipo rispetto alla probabile impennata delle tariffe doganali dell’UE. Byd sta realizzando un impianto in Ungheria, che sarà operativo all’inizio del 2027, mentre Chery ha recentemente siglato un accordo con la spagnola Ev Motors per la riqualifica di un ex stabilimento Nissan a Barcellona. La competizione cinese potrebbe intensificarsi nel segmento dei veicoli a basso costo, dato il suo predominio tecnologico e la capacità di ridurre i costi di produzione. In risposta, paesi come gli Stati Uniti e l’UE potrebbero rafforzare misure protezionistiche per proteggere le industrie locali, aumentando la frammentazione del mercato globale dell’automotive. Il rischio è di vedere una diminuzione della cooperazione internazionale nei settori chiave per la transizione energetica.
Strategie per l’Europa: mitigare l’impatto dello scontro commerciale
L’UE, seguendo una linea simile a quella adottata dagli Stati Uniti, ha recentemente introdotto dazi significativi sulle auto elettriche cinesi per contrastare il dumping e proteggere l’industria automobilistica europea, che rappresenta circa 14 milioni di posti di lavoro. A partire dal 31 ottobre, i nuovi dazi definitivi hanno raggiunto il 45%, sommandosi all’obolo del 10% precedentemente in vigore. La tassazione varia dal 7,8% per le Tesla prodotte a Shanghai al 35,3% per Saic, con un’aliquota intermedia del 20,7% per i produttori che hanno collaborato con Bruxelles. Queste misure dureranno cinque anni e rappresentano un tentativo di difendere un settore in difficoltà, rischiando però di aumentare le tensioni commerciali con Pechino e sollevando più in generale dei dubbi sull’efficacia di misure del genere. La domanda che molti esperti di politica industriale si fanno è se è possibile far crescere un’industria all’ombra dei dazi o se, come vedremo in seguito, bisogna piuttosto investire nell’accelerare e potenziare la crescita del settore, in una logica però sempre di mercato.
In risposta a questa manovra, la Cina ha definito i dazi UE una forma di “protezionismo commerciale”, formalizzando la contestazione e presentandola nel novembre del 2024 all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Parallelamente, sul piano commerciale ha avviato delle contromisure, tra cui sanzioni su prodotti europei come brandy, formaggi e carne di maiale. Pechino sta anche considerando l’aumento delle aliquote sulle auto europee di grossa cilindrata, minacciando un settore cruciale per Paesi come la Germania. Questi attriti riflettono una crescente disputa economica che si estende oltre le auto elettriche, coinvolgendo anche pannelli solari e turbine eoliche.
In questo contesto, l’UE deve affrontare un delicato bilanciamento tra il mantenimento di relazioni commerciali con Stati Uniti e Cina. Una strategia chiave potrebbe essere quella di rafforzare la propria autonomia tecnologica e produttiva nel settore EV attraverso investimenti nelle catene di fornitura per batterie e minerali critici, oltre a incentivi per le industrie locali. Parallelamente, l’UE potrebbe negoziare con gli Stati Uniti per evitare misure protezionistiche unilaterali, sottolineando l’importanza di una cooperazione transatlantica per competere con la Cina. Tuttavia, le divisioni interne tra i Paesi membri rischiano di indebolire la posizione negoziale dell’Europa. Da valutare saranno anche le ricadute commerciali sulle prese di posizione in merito alle guerre in corso. Ciò potrebbe aprire la porta ad accordi commerciali che in un recente passato sarebbero sembrati poco plausibili, ma potrebbe anche comportare un compromesso nel conflitto Russia-Ucraina che allargherebbe le fratture interne all’Unione Europea. Queste tensioni emergono dalle diverse priorità degli Stati membri: Polonia e Paesi Baltici, tanto vicini geograficamente quanto storicamente ostili alla Russia, spingono per una linea dura contro Mosca, mentre Stati come Ungheria e Italia, che al grande Paese asiatico sono legati da interessi energetici ed economici, potrebbero favorire soluzioni diplomatiche più concilianti. Tale spaccatura renderebbe difficile una posizione comune e coerente dell’UE in caso di accordi tra queste due superpotenze mondiali.