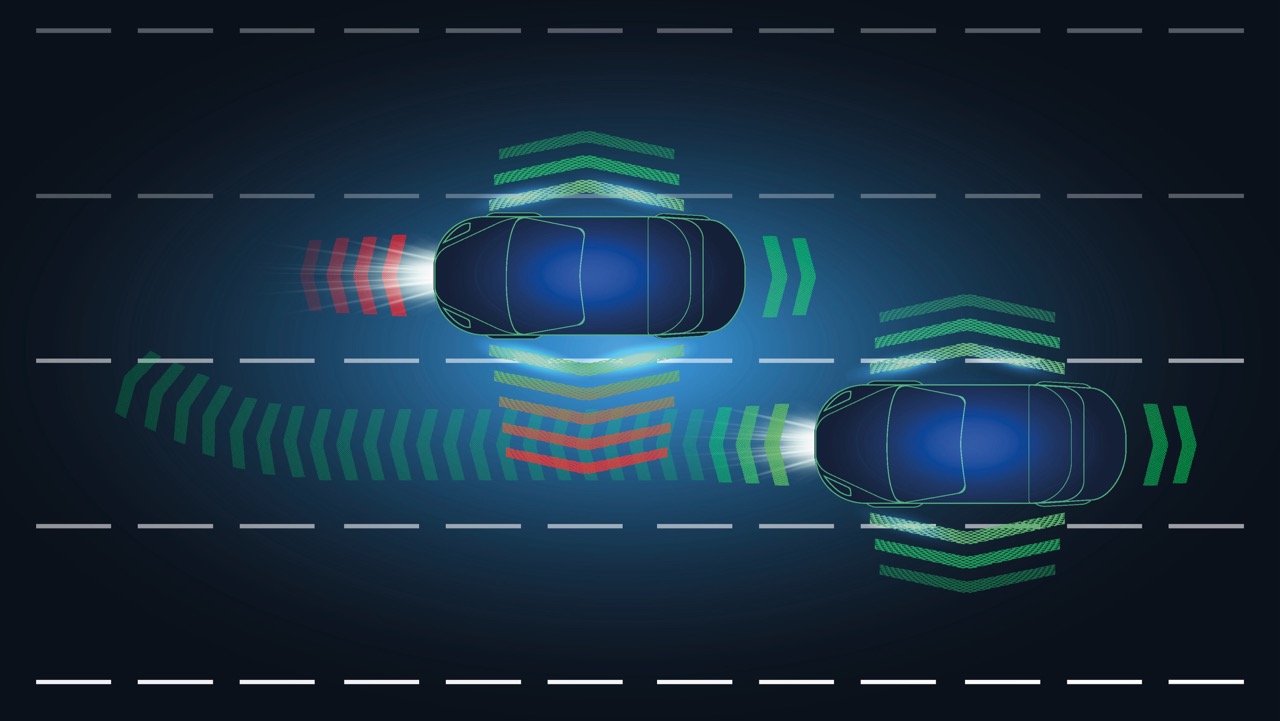Turismo e mobilità sostenibile come vettori di sviluppo per il sistema Paese Italia
Nel 2023, l’Italia ha totalizzato 447 milioni di presenze turistiche (dati Istat), classificandosi al terzo posto in Europa dopo Spagna e Francia, e al quarto posto per numero di arrivi turistici (il primo dato calcola i pernottamenti, il secondo quante persone visitano il Paese). Il turismo è una risorsa economica sempre più importante, che contribuisce al 18% del Pil nazionale nel 2024 (secondo i dati elaborati dall’Università Tor Vergata di Roma) ma che affronta anche alcune criticità.
La pressione esercitata dal fenomeno dell’overtourism è una delle sfide più difficili. Ad esempio, Venezia, che copre solo lo 0,1% della superficie italiana, accoglie il 12% dei turisti totali del Paese, con ripercussioni sul patrimonio artistico, sull’ambiente e sulla qualità della vita delle comunità locali. Ma questa sfida rappresenta anche un’opportunità per promuovere territori meno conosciuti, che spesso si trovano a pochi chilometri dalle mete più frequentate dai flussi di visitatori.
Allo stesso tempo, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano minacce crescenti per molte delle attrazioni naturali italiane. In questo contesto, il turismo sostenibile può essere inteso come una leva che contribuisce a garantire un futuro migliore a tutto il Paese, rendendo il suo territorio più resiliente attraverso infrastrutture e politiche green al servizio sia dei “residenti temporanei” sia di coloro che vivono i territori tutto l’anno.
Piattaforme digitali ed esperienze su misura
Il turismo sostenibile punta a bilanciare le dimensioni economiche, sociali e ambientali, offrendo un modello innovativo che possa tutelare il patrimonio italiano e rispondere alle esigenze delle comunità locali e dei visitatori. Un elemento chiave è la gestione più equilibrata dei flussi turistici. Attrazioni meno note, ma ricche di valore culturale e naturale, possono essere promosse per distribuire i flussi e alleggerire la pressione sulle destinazioni più affollate come Roma o Firenze.
La digitalizzazione gioca un ruolo cruciale in questo processo. Il piano “Digital and Sustainable Tourism Hub”, finanziato con 114 miliardi di euro dal PNRR entro il 2026, mira a creare piattaforme digitali per migliorare la gestione dei flussi turistici e offrire esperienze personalizzate. L’adozione di tecnologie smart permetterà inoltre di integrare le informazioni turistiche in tempo reale, ottimizzando la fruibilità delle destinazioni.
Un altro aspetto essenziale è la promozione del turismo esperienziale e destagionalizzato. L’Italia, con i suoi 892 prodotti DOP e IGP, è leader mondiale nell’enogastronomia, un elemento apprezzato dal 70% dei turisti stranieri e italiani che desiderano scoprire la cultura locale attraverso la cucina e i food tour, secondo una ricerca dell’Osservatorio Do Eat Better Experience. Questo approccio non solo valorizza le eccellenze locali, ma incoraggia una distribuzione più uniforme dei flussi durante tutto l’anno.
L’infrastruttura elettrica come fattore competitivo
Un elemento chiave per il successo del turismo sostenibile in Italia è la trasformazione del sistema dei trasporti. Investire nella mobilità sostenibile – come reti ferroviarie potenziate, trasporti pubblici elettrici e percorsi ciclabili – può ridurre significativamente l’impatto ambientale, e non solo, dei flussi turistici.
Sul fronte della copertura di colonnine elettriche destinate alla ricarica delle automobili, stando ai dati di Eviaggio sono oltre 2300 le strutture alberghiere e i ristoranti che mettono a disposizione questo servizio per i turisti. Tra le regioni virtuose in testa il Trentino-Alto Adige, con oltre 550 stazioni di ricarica nelle strutture turistiche del territorio, seguito dalla Lombardia con poco meno di 300 e dal Veneto che ne conta 250.
La ricarica in hotel è ormai diventata un fattore distintivo che rende più competitive le strutture che l’adottano. Di più: guardando la questione da un’altra angolatura, l’assenza di infrastrutture a supporto dei viaggiatori “full electric” può diventare un fattore escludente, in grado di orientare la scelta del turista verso altre mete più attrezzate. Non a caso, il mondo delle guide turistiche ed enogastronomiche si sta da tempo orientando in questa direzione, investendo la propria autorevolezza nel segnalare gli operatori che si impegnano in modo serio e concreto nel contenere la propria “impronta climatica”. Se parliamo di turismo enogastronomico, ad esempio, merita una citazione la guida Vinibuoni d’Italia, che da alcuni anni evidenzia con un’apposita icona le aziende vitivinicole che hanno adottato, in vigneto e in cantina, criteri e tecniche di produzione sostenibili. Non solo: la guida indica anche, nell’anagrafica delle cantine segnalate, chi offre il servizio di ricarica per veicoli elettrici e quali sono più bike friendly.
Seguendo questa strada, ecco che il turismo sostenibile può diventare un vettore che abilita l’infrastrutturazione dei territori. Non è un caso, ad esempio, che nel 2023 sia stata inaugura proprio ad Affi, dove si trova l’uscita autostradale attraverso cui transitano grandi flussi turistici diretti da Germania e Austria al lago di Garda, la più grande stazione di ricarica d’Europa del network Ionity, joint venture promossa da BMW, Ford, Hyundai, Mercedes e Volkswagen. Un’area di rifornimento nata per soddisfare una domanda turistica estera, ma che resta sul territorio a disposizione di tutti. Italiani compresi.
Obiettivo intermodalità
Mobilità sostenibile significa anche far dialogare tra di loro le scelte di trasporto, in un’ottica di interconnessione. Sistemi di trasporto intermodali, che collegano in modo efficiente stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, ciclovie e destinazioni turistiche, non solo migliorano l’accessibilità alle località meno note, ma riducono la dipendenza dai trasporti privati, spesso associati a emissioni di CO₂ elevate.
Un passo in questa direzione è rappresentato, ad esempio, da un accordo stretto nel 2024 tra le società Navigazione Laghi e Trenitalia per favorire l’intermodalità tra trasporto su battello e treno per viaggiare verso i più grandi laghi del Nord Italia: Garda, Maggiore e di Como.
Ampi margini di crescita potrà avere nei prossimi anni proprio il turismo ferroviario, un filone su cui ha deciso di puntare nell’estate 2023 il Gruppo Ferrovie dello Stato costituendo la nuova società FS Treni Turistici Italiani. Sono tre i segmenti di mercato in cui opera: il lusso, con il rilancio del brand storico dell’Orient Express, con un’offerta esclusiva che mira ai turisti alto-spendenti; l’Espresso e i treni storici, anche notturni, che mirano alle mete più frequentate con una programmazione tarata in base alla stagionalità dei flussi, ma offrono anche la riscoperta di luoghi meno noti e di grande valore storico e paesaggistico, integrando il viaggio su rotaia con visite guidate, percorsi pedonali e degustazioni; infine il segmento Omnibus-Regionali, con percorsi ad hoc nei fine settimana e tariffe accessibili a tutti. Una buona pratica ci arriva dal Mezzogiorno, dove grazie alla sinergia tra Ferrovie dello Stato e Associazione ferrovie della Calabria sono stati portati sui binari 20 treni turistici nell’estate 2024, con diversi itinerari proposti che hanno messo in rete, lungo la Regione, borghi storici, mare, aree interne, degustazioni e offerta culturale.
L’estensione di piste ciclabili e percorsi dedicati al cicloturismo – una tipologia di turismo che in termini economici registra oltre 5,5 miliardi di euro al 2023, in crescita del 35% sul 2022 e del 19,1% sul 2019 – consente di attirare visitatori attenti alla sostenibilità e alle esperienze outdoor. Sarebbe sbagliato intendere quello su due ruote come un mezzo di trasporto adatto solo alle brevi distanze: soprattutto nel Nord Europa le ciclovie sono progettate, al pari delle autostrade, come corridoi attrezzati per coprire medie e lunghe distanze. Il progetto EuroVelo, promosso dalla European Cyclists’ Federation, mira a realizzare una rete transeuropea di ciclovie lunga 90 mila chilometri, tre delle quali attraversano l’Italia: la Ciclovia Mediterranea, da Cadice ad Atene e a Cipro, di cui la ciclovia del Po è parte integrante; la Ciclovia Romea-Francigena, che porta da Londra a Brindisi passando per Roma; la Ciclovia del Sole che collega Capo Nord e Malta attraverso la Sicilia.
Uno studio di Enit e Touring Club Italiano presentato alla fiera Bit di Milano nel febbraio 2024 ha stimato che il turismo lento – etichetta che tiene insieme il cicloturismo e i cammini – abbia in Italia circa 3,6 milioni di praticanti, con numeri anche più interessanti all’estero. In Francia il mercato potenziale è di 4,8 milioni di persone, 5,6 in Germania e 7,1 nel Regno Unito, tutti mercati che indicano proprio l’Italia come meta ideale per una “vacanza lenta”. Le regioni scelte dagli italiani vedono al primo posto il Trentino-Alto Adige, seguito da Toscana, Umbria e Sicilia. I francesi e gli inglesi prediligono la Sicilia, e al secondo posto mettono la Toscana. Parti invertite per i tedeschi che sognano la Toscana e, in seconda battuta, la Sicilia. Secondo la ricerca di Enit e TCI il solo turismo escursionistico (solo a piedi) sta conquistando una fetta di mercato che in Italia è stimata in 2,7 milioni di praticanti, in Francia 4,5 milioni, 4,6 in Germania e 5,4 nel Regno Unito. Numeri tutt’altro che trascurabili.
La crescente consapevolezza degli impatti negativi dell’overtourism sta facendo crescere la sensibilità a livello internazionale sulle alternative più sostenibili in termini ambientali, economici e sociali. Una strategia sempre più diffusa, citata nella ricerca Expedia Unpack 2024, è quella dei Destination Dupes: si tratta di destinazioni alternative rispetto a quelle più affollate, meno note ma non meno interessanti. «Queste destinazioni sono un po’ inaspettate e a volte più convenienti o sostenibili, ma altrettanto piacevoli delle mete tradizionali – si legge nel report –. Un viaggiatore su tre ha prenotato una Destination Dupe in passato, e il 50% dei viaggiatori nella fascia d’età 25-34 anni ne ha prenotata una, il dato più alto di qualsiasi altra fascia d’età». Diverse le motivazioni che spingono i viaggiatori a scegliere queste mete alternative: si va dalla convenienza (per il 45% degli intervistati) all’opportunità di vivere una più profonda interazione con la cultura locale (36%) fino al supporto a un’idea e una pratica di turismo sostenibile (24%).
Le opportunità per l’Italia, tra fondi e governance
Con 60 siti UNESCO, l’Italia possiede un patrimonio unico che, se valorizzato con strategie sostenibili, può attrarre un turismo di qualità e alto valore aggiunto. I fondi nazionali ed europei rappresentano un’occasione da non perdere. Tra questi, lo stanziamento del Ministero del turismo da 25 milioni di euro per progetti di turismo sostenibile da realizzarsi da il 2023 e il 2025 che ha delle finalità chiare: destagionalizzazione e itinerari innovativi, intermodalità nei trasporti, conseguimento di certificazioni di sostenibilità per strutture ricettive e imprese turistiche.
Ma i fondi da soli non sono sufficienti se non rientrano in una strategia comune che tenga insieme gli stakeholder, dagli operatori privati alle pubbliche amministrazioni passando per le tante figure professionali coinvolte. Un ruolo di governance sempre più spesso è interpretato dalle DMO – Destination Management Organization, che in forme diverse in base alle caratteristiche dei territori fungono (o dovrebbero farlo) da catalizzatori delle diverse istanze e promotori di strategie condivise in un contesto di eccessiva frammentazione delle destinazioni turistiche.
Una strada interessante per rafforzare la transizione del turismo verso la sostenibilità è quella delle certificazioni. La più autorevole è quella erogata dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC) è l’organismo internazionale nato dall’United Nations Environment Programme e dalla United Nation World Tourism Organization, per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel turismo. L’ente ha costruito criteri di sostenibilità sulla base di decenni di lavoro ed esperienze precedenti in tutto il mondo. In Italia questa certificazione è stata ad oggi ottenuta da una ventina di località e strutture ricettive, concentrate soprattutto in Alto Adige, Trentino e Toscana. Siena nel febbraio del 2023 è stata la prima città d’arte a ottenere la certificazione GSTC, avviando un percorso che ha portato nell’anno successivo all’adozione del primo Piano Strategico del Turismo, intitolato “Per un Buon Governo del turismo a Siena” e valido dal 2024 al 2030.